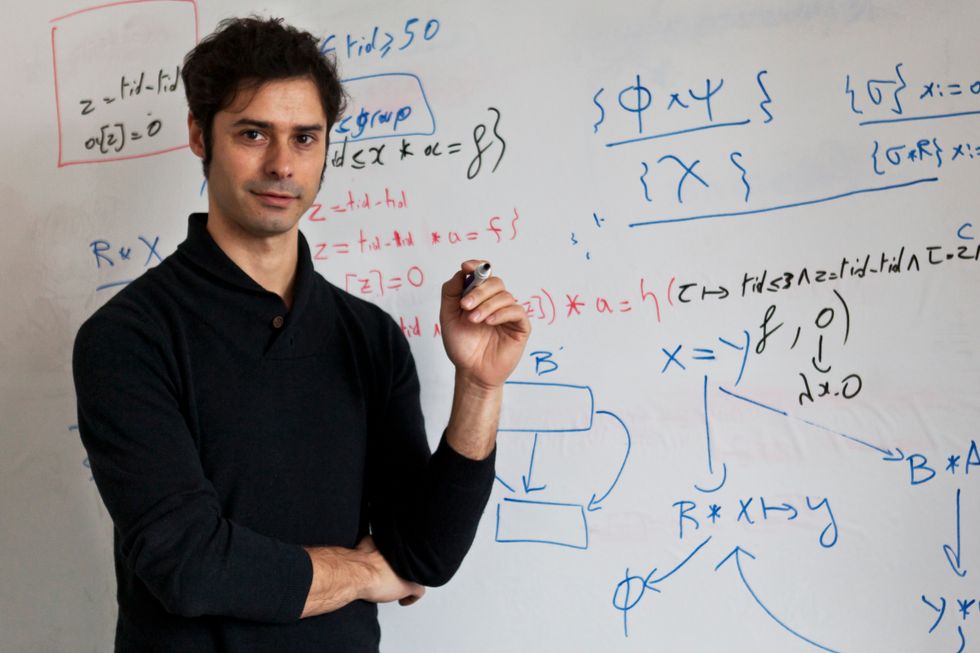Dino Distefano, genio dell'informatica che l'Italia non ha voluto
Scartato all'Università di Pisa, a Londra ha creato un software che stana gli errori di sistema, conquistando un premio prestigioso
Si è innamorato della matematica guardando il padre dipingere. Ma Dino Distefano a dipingere come suo padre non ha mai imparato. Fu così che da bambino decise di usare al posto delle tempere i numeri, con i simboli si costruì una tavolozza speciale: «Creare un programma informatico per me è stato come disegnare un quadro astratto, imitare mio padre». Dove tutti vedevano lettere e simboli, Dino cominciò a vedere colori da mescolare, una lavagna di equazioni da riordinare, anzi, una lingua tutta da scrivere, quella che lo ha portato a vincere il mese scorso, il Roger Needham Award, (per alcuni è il Nobel dell’informatica) a conquistare l’Olanda, convincere i londinesi a dargli a 39 anni la cattedra di professore ordinario d’Informatica alla Queen Mary University e inventare il software dei software, il “vaccino” che impedisce ai sistemi informatici di paralizzarsi.
Solo la sua professoressa delle scuole medie di Biancavilla, paese in provincia di Catania dove è nato, non riusciva a convincere quando lo vedeva intento a cercare altri metodi per risolvere un’equazione: «E’ impossibile Dino, impossibile». Eppure per Dino, un altro metodo doveva pur esserci, al punto da riempire fogli su fogli, impiastricciare x, y, spostare i numeri dal primo al secondo termine, sempre cercando un’altra combinazione, la chiave che potesse aprire quel grimaldello di numeri.
Sarebbe genio o talento o forse meglio ostinazione, perseveranza, la stessa con cui persuase il padre, quattro figli, professore di francese e la madre casalinga e farsi regalare il primo Commodore 64. Erano gli anni dei pionieri del computer, quando i pc erano scatole di plastica adatte per chi non sapeva giocare al calcio, per chi passava il pomeriggio a vedere i telefilm sulle televisioni private. «Come si chiama… Caspita non ricordo, ma c’era un telefilm in cui un bambino prodigio aggiustava il mondo con il suo pc. Volevo essere quel bambino». Ma Dino un prodigio non lo era. Una scuola «dove ha imparato a firmare gli assegni», istituto per ragionieri a Paternò tra pistacchieti e cemento con un indirizzo per programmatori. Voti nella media se non fosse per il fuoco per l’informatica che condivideva con Salvo e Giuseppe, altri amici che iniziavano a immaginare programmi informatici negli anni in cui l’informatica era un vuoto refrain.
«Quando ho iniziato, l’informatica era tutta da scoprire ed io un ragazzo che passava per strano», ricorda Dino, lo stesso Dino che a tredici anni s’inventava un database, un archivio per catalogare i libri di casa sua, lo stesso che da matricola preferì andarsene a Pisa piuttosto che rimanere a Catania E infatti fu a Pisa che decise di iniziare. Prima materia voto 28/30, “Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici” e poi la prima borsa di studio vinta, le tasse ridotte al minimo per merito e la mensa gratuita, allora una conquista pari a un Nobel: «Se non avessi avuto quell’aiuto da parte dello Stato, non ce l’avrei mai fatta. La mia è la solita famiglia modesta che non poteva certo permettersi i miei studi, inoltre eravamo quattro figli». Di materia in materia, superando perfino l’Analisi 1, risiedendo come intermezzo un anno in Olanda grazie all’Erasmus e infine laurearsi in 4 anni e mezzo.
Dopo è un viaggio in giro per il mondo grazie a un rifiuto da parte dell’accademia italiana. Al concorso per un posto di dottorato a Pisa, Dino viene escluso e la ragione non è una accusa facile e piena di rancore nei confronti dell’università: «In Italia siamo troppo bravi, c’è una competizione altissima per pochissimi posti. Non voglio pensare che l’Università mi abbia chiuso le porte per aprirle ad altri. Penso soltanto che è difficile scegliere quando sono tutti eccellenti e bravi». Rimandato dunque, buono tutt’al più per fare un anno di servizio civile a Fiesole accompagnando i bambini sullo scuolabus o ad affrancare multe all’ufficio postale. L’ultima busta affrancata, però, è quella di Dino. Un curriculum spedito in Olanda all’università di Twente, un altro in Svezia all’università di Stoccolma. Entrambi lo vogliono, ma alla fine sceglie l’Olanda.
Quattro anni di studio capitalizzando il frutto della sua tesi «Semantica dei linguaggi di programmazione». Pensate alla fisica, alle regole grazie alle quali gli ingegneri costruiscono i ponti. A consigliarlo è lo stesso Dino: «E’ come creare le fondamenta per far stare in piedi un ponte, in questo caso dei software. Siamo dei fisici dell’informatica per usare una similitudine. Cos’è alla fine il nostro tentativo? Nient’altro che esprimere dei concetti in modo preciso, togliere al mondo l’ambiguità». E quattro anni possono bastare per togliere ambiguità al suo futuro. L’occasione è un posto al fianco di uno dei “maestri” dell’informatica.
Si chiama Peter O’Hearn e insegna a Londra. Nel suo studio solo un divanetto e una lavagna. Nel Novembre del 2003 Dino si presenta. Lui lo guarda e gli dice: «Bene, fammi vedere su cosa hai lavorato». «Che devo fare professore?», gli chiede Dino. «Vai alla lavagna per cominciare». Dino va alla lavagna e inizia a mettere cifre e codici in fila. Il professore lo guarda e gli si avvicina: «E se facessimo così, oppure così?». Passano sette ore e dopo due giorni gli offre un ruolo da ricercatore: «Puoi iniziare a Gennaio se vuoi». Sarà la vertigine, la vigilia dei trionfi, ma Dino si ferma a riflettere. Usa tutta la sua impudenza italiana, impudenza buona: «Posso iniziare professore, ma solo a Marzo, prima giro il mondo un po’».
O’Hearn rimane in silenzio. Dino potrebbe perdere tutto o vincere per rialzo con quel coraggio che possiedono solo i giocatori per necessità, quelli che si nutrono dell’azzardo come medicina. Ma lo capirà questo professore inglese? Dino, forse, ha perso tutto. Il professore: «Uhm, va bene. Arrivederci a Marzo quindi». E’ come un numero della roulette e quel professore un croupier: «Hai vinto, Dino».Thailandia, Laos, Singapore, Australia, Bolivia, Cile, Perù, finito il giro Dino torna a Londra e riceve la sua prima paga da dottore di ricerca. In Inghilterra lo Stato gli affida pure una borsa per un progetto personale e due ricercatori ad affiancarlo. Non ha vincoli di orari, ne l’obbligo di presentarsi a lavoro tutti i giorni, perché da sempre le idee e le scoperte sono un orologio che non gira, una passeggiata a pochi passi dalla City ad Hackney dove ha comprato casa, una chiacchierata sotto la pioggia. Dino inizia alle 10 di mattina continua fino alle 18 poi va al pub insieme ai suoi colleghi «perché la ricerca continua anche scambiandosi mail fino a tarda notte».
Ed è a Londra che conosce Cristiano Calcagno, genovese, uno di quelli che vorrebbe aggiustare il mondo con un tasto. Insieme si mettono a lavorare sull’errore, giovani Auguste Dupin del guasto dei sistemi informatici. Vogliono fare i visionari, prevedere prima che si verifichino i difetti su un aereo, su un’auto. Come dei detective, mettono insieme ipotesi, algoritmi, tutto per cercare la falla, eliminarla o almeno ridurla, trovare un modo scalabile da applicare ai grandi sistemi informatici. E’ il passaggio dalla scoperta all’applicazione pratica, che è la fatica e la scommessa di qualsiasi inventore: la transizione dall’astratto al reale. Ci riescono e sono due italiani, tanto da decidere nel 2009 di commerciare l’applicazione e creare una sturt up: la Monoidics. 8 assunti, un ufficio in Giappone, clienti come la Mitsubishi, Airbus, Toyota e una scoperta che vale il premio che nel mondo di Dino è definito il Nobel dell’informatica: «Ma non è un Nobel – si schernisce Dino – non esageriamo.
Viene assegnato alla miglior progetto a dieci anni dal conseguimento del dottorato». E però, nel successo si misura l’impossibilità di eliminare l’errore, la pochezza dell’uomo, la grandezza infinitesimale di qualcosa che non si riuscirà mai a eliminare. «Esisterà sempre l’errore, è impensabile eliminarlo. Anche noi cerchiamo di descriverlo, ma la descrizione è imperfetta perché anche la lingua è sempre imperfetta, come diceva Turing, ci sono problemi indecidibili. Noi possiamo ridurli, almeno ci proviamo». Il più grande errore dell’Italia, (ma poi chi lo ha detto sia un errore?) è invece una felice equazione, un disegno astratto fatto da un pittore che cercava altre combinazioni e stagioni, una password di sole quattro lettere. Dino.